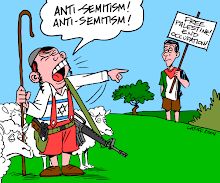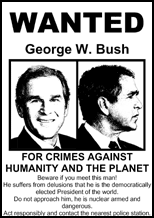Negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare sempre di più di energie pulite e rinnovabili. Anche per effetto delle denunce di Beppe Grillo, i nostri politici sembrano essersi convertiti a queste necessità. Ma è vero quello che ci dicono? O per loro rappresenta solo l'ennesima occasione di guadagno personale? Non essendo un esperto in materia ho affidato il compito all'esimio ing. Mairic Ivanov. Il post va a contribuire (anche se decisamente in ritardo - era per il 15 ottobre 2007) alla campagna Blog Action Day il cui tema era quest'anno l'ambiente.
1. Se non ricordo male, la centrale detta Turbogas si differenzia dalla classica centrale termica (o termoelettrica) per il motivo seguente: la termoelettrica brucia un combustibile che può essere di varia natura, in origine era il carbone (uno dei motivi dell'avanguardia inglese nello sviluppo capitalistico).
Attualmente si bruciano prodotti di raffinazione del petrolio, ma si possono usare anche gas naturale e metano (eh sì, il preziosissimo gas del figlio di Putin serve anche a questo), per motivi di costo e per il fatto che il metano in combustione diventa vapore acqueo e anidride carbonica, che farà (forse) male per l'effetto serra, ma non è in alcun modo tossica, mentre i derivati del petrolio rilasciano in genere monossido di carbonio - che è quello che vi uccide se vi suicidate col tubo di scappamento in auto e che ogni tanto stecchisce nel sonno incauti utilizzatori di stufette.
2. Comunque, qualunque sia la natura del combustibile (che può essere al limite anche uranio o plutonio, si chiamano infatti centrali termonucleari), esso alimenta una vera e propria CALDAIA dove viene fatta bollire l'acqua e portata a pressioni molto elevate. Ottenuta questa "pentola a pressione", la si fa sfiatare dentro una turbina: le pale girano con questo 'sfiato' e azionano degli alternatori i quali [...] producono corrente elettrica e vi potete appicciare il computer per leggere queste pallosissime cazzate! Quello che sfiata dalla turbina è vapore (inquinamento solo di tipo termico), mentre quello che esce dalla caldaia dipende da cosa si è bruciato. Perciò, quando vi parlano di centrali a "carbone pulito" potete farvi una grassa risata.
Sostanzialmente e concettualmente, non c'è niente di diverso dalla prima macchina a vapore di Watt, solo che mentre in quel caso il vapore azionava direttamente congegni meccanici (le macchine tessili a cui quei bastardi inglesi avevano incatenato il proletariato espropriato dalle common lands e contro le quali si scagliò l'indimenticato John Ludd) nel caso delle centrali elettriche ad essere azionato è un congegno che trasforma l'energia meccanica in elettrica, l'alternatore appunto. Il problema di questi impianti è il rendimento e si riallaccia sulla giusta osservazione sul "presioso" gas. Infatti nel passaggio dell'energia da chimica ("contenuta" nel combustibile) a termica (combustione) a meccanica (pale rotanti) a elettrica, o meglio, in ognuno di questi passaggi, una parte dell'energia iniziale - manco tanto piccola - se ne va a puttane come calore disperso nell'atmosfera. A spanne e mediamente, circa la metà diventa energia elettrica (e manco sempre). Si capisce che il problema di ricavare la massima energia elettrica da una data quantità di combustibile (scarsa! e qui entra in gioco l'economia...) non è da poco conto, co' sti chiari di luna: Putin per l'appunto, Ahmadinejad, Chàvez etc. che guarda un po' se sti stronzi di sottosviluppati TERZO MONDO ci debbano negare così i loro carburanti! (e qui entra in gioco la politica).
3. Premesso che c'è un modo per alzare un po' i rendimenti (impianti di cogenerazione per esempio, recuperi un po' di calore che andrebbe disperso per riscaldare gli ambienti o l'acqua per uso civile), restano comunque non alti.
Molto di più lo sono invece quelli delle centrali dette Turbogas. In questo caso infatti, il combustibile non serve a scaldare e far evaporare l'acqua, ma, bruciando, crea una nube con i prodotti della combustione stessa (a temperatura più alta e pressioni maggiori del vapore) che viene poi fatta sfiatare direttamente per azionare le pale della turbina. L'energia meccanica trasmessa è maggiore, inoltre c'è un trasferimento di energia in meno (dal combustibile al gas), va da sé che i rendimenti sono più alti, cioè a parità di roba bruciata, produco più energia elettrica (che è quella che ci interessa, perché è la più facilmente distribuibile).
In questo caso il ciclo assomiglia molto a quello dei motori a scoppio - nelle versioni Otto e Von Diesel, quello che poi inventò i famosi jeans (hehehe!) - in cui l'espansione dovuta al liquido che brucia è trasformata direttamente in energia meccanica muovendo i pistoni del motore.
Dunque, se la prima potevamo assimilarla ad una megapentola a pressione, questa potremmo assimilarla ad una mega-automobile (ferma però). Quello che sfiata dalla turbina però in questo caso non è vapore, ma i prodotti di combustione, compresi un po' di monossido, idrocarburi incombusti, qualche polvere sottile, e tutte quelle belle cosucce che possono uscire dallo scappamento della macchina. Poi si catalizza anche lì quanto ti pare, ma vattela a respirare tu la marmitta della macchina!!! Questo spiega anche perché nessuno le voglia vicino casa. Anche perché - ma dovrei verificare - mi pare che non si usi il gas naturale e/o il metano, perché l'espansione in combustione di gas è minore di quella dei liquidi e da questa dipende la pressione con cui 'sfiata' (anche intuitivamente). Tra l'altro il metano ha rischi di detonazione a certe pressioni - vedi incauti manutentori di caldaie/tubature che poi salta per aria un palazzo all'improvviso...
4. Detto questo non credo nemmeno che l'Enel ci abbasserà la bolletta per metterci un mega-tir in casa, e se anche fosse non credo che il risparmio basterebbe a pagarsi le cure e le medicine anticancro... effettivamente servirebbe il parere di un medico/epidemiologo, ma l'elettrocarbonium (qui ad Ascoli Piceno) ce la ricordiamo con i suoi tumori alla vescica e alle ossa; non voglio dire che sia la stessa cosa, ma sarebbe spiacevole scoprire DOPO che la cosa era cancerogena - intendo quando già ce l'hai, no?
Poi se uno dicesse che queste iniziative andrebbero sabotate, gli si dà del terrorista... che brutte munne! Vi ho annoiato, lo so, immagino il giramento di pale, ma non c'era un modo migliore di spiegarsi... poi lo capite perché tanti anni di ingegneria ingenerano turbe psichiche???
ing. Mairic Ivanov
APPROFONDIMENTI (video):