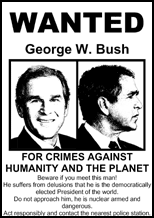Secondo il diritto internazionale uno Stato, per essere considerato tale, deve possedere 3 caratteristiche sostanziali: un popolo (stanziato in un dato territorio e con una propria coscienza politica senza la necessità che risulti omogeneo in aspetti quali la cultura, la religione, etc, su cui esercitare il controllo), un territorio (il controllo va esercitato su di uno specifico territorio, pur non essendo importante che i suoi confini siano esattamente delineati) e una sovranità reale sul territorio e sul popolo (tanto interna - la capacità di uno stato di esercitare il proprio imperio all'interno del proprio territorio – quanto esterna - la capacità di esercitare il governo di una regione e di un popolo indipendentemente da ingerenze di altri stati). Da ciò deriva che i requisiti della soggettività internazionale dello Stato sono rintracciabili nella sua effettività, ossia nel controllo effettivo di una comunità territoriale (dal momento che la nascita di uno Stato è un processo ‘di fatto’ o politico o storico, e non giuridico, almeno secondo la communis opinio) e nella sua indipendenza, ossia nel fatto che l’organizzazione di governo non dipenda da un altro Stato (la cosiddetta indipendenza dello Stato-organizzazione). In particolare, il requisito dell’indipendenza va inteso cum grano salis. Se lo si volesse intendere come assoluta possibilità di determinarsi da sé, si giungerebbe alla conclusione che nessuno Stato (e forse nemmeno le grandi Potenze) sia soggetto di diritto internazionale, essendo l’interdipendenza una delle caratteristiche oggigiorno sempre più marcate delle relazioni internazionali. Che dire poi degli ‘Stati satelliti’, della sovranità limitata, della presenza di basi e truppe straniere, e di tutti gli altri condizionamenti messi in atto dagli Stati più forti nei confronti dei più deboli? Dove porre allora il limite oltre il quale non c’è indipendenza e, quindi, non c’è soggettività internazionale?
Nella dottrina prevalente (cfr. per esempio CONFORTI) si ritiene che non possa che farsi leva su di un dato formale: è indipendente e sovrano lo Stato il cui ordinamento sia originario, tragga la sua legittimità e forza giuridica da una propria Costituzione e non da quella (a volte anche imposta) di un altro Stato [1]. Il che permette di spiegare – tra l’altro – perché normalmente si ritenga che non influiscano sulla soggettività la dimensione dello Stato, la sua pacificità e democraticità, nonché l’estensione materiale delle sue risorse economiche (si pensi, tra tutti, a San Marino e al Lichtenstein). Una sola eccezione può forse ammettersi (CRAWFORD): il dato formale non può più invocarsi – e deve cedere di fronte al dato reale – quando l’ingerenza da parte di un altro Stato nell’esercizio del potere di governo è totale, quando cioè il Governo indigeno è di fatto un ‘Governo fantoccio’ [2]. L’organizzazione di governo che eserciti effettivamente ed indipendentemente il proprio potere su di una comunità territoriale diviene soggetto internazionale in modo automatico. Non è infatti necessario che essa sia riconosciuta dagli altri Stati. Solo per fare qualche esempio, si sa che l’Italia riconobbe la Repubblica democratica tedesca (e viceversa) solo nel 1973; che gli Usa e la Cina si riconobbero reciprocamente solo nel 1978-79, epoca in cui cessarono i rapporti diplomatici tra i primi e Taiwan; che la maggior parte degli Stati arabi non riconosce Israele; che l’Italia ed altri paesi hanno riconosciuto Croazia e Slovenia – proclamatesi indipendenti per scissione dall’ex-Jugoslavia – nel 1992. Orbene, tutto ciò ha scarsa rilevanza giuridica, dal momento che per il diritto internazionale – almeno secondo l’opinione che meglio corrisponde alla prassi seguita dagli Stati – il riconoscimento è un atto meramente lecito, così come il non-riconoscimento: entrambi non producono conseguenze giuridiche [3].
Il riconoscimento appartiene, insomma, alla sfera squisitamente politica (QUADRI) e rivela null’altro che l’intenzione di stringere rapporti, scambiare rappresentanze diplomatiche e avviare forme di collaborazione che, a seconda del loro grado di intensità, viene solitamente sottolineata dalla formula del riconoscimento de jure o de facto [4]. Quando si nega valore giuridico al riconoscimento – atto in ordine al quale le più varie teorie sono state sostenute – si viene a respingere soprattutto la tesi che esso sia costitutivo [5] della personalità internazionale. Si viene cioè a respingere la tesi secondo cui, affermandosi una nuova organizzazione di governo con i caratteri dell’effettività e dell’indipendenza, gli Stati pre-esistenti possano esercitare nei suoi confronti (appunto mediante il riconoscimento) una sorta di potere di ammissione nella comunità internazionale [6]. Bisogna però ammettere che tale tesi ha il merito di cogliere una tendenza che è stata sempre presente nella prassi internazionale, anche se non è mai riuscita a tradursi in precise norme giuridiche. Gli Stati pre-esistenti tendono, infatti, a giudicare se il nuovo Stato meriti o meno la soggettività, ancorando il loro giudizio ad un certo valore o ad una certa ideologia (come del resto ha fatto Bush nel caso del Kosovo): se in passato si usava non riconoscere uno Stato che non fosse monarchico o non fosse cristiano, in epoca attuale si tende a sostenere che non siano da riconoscere come soggetti internazionali i Governi affermatisi con la forza, gli Stati ‘non democratici’, quelli ‘non amanti della pace’ o che violano i diritti umani, etc. L’unica verità in tutto ciò è che questa tendenza non si è mai tradotta in norme internazionali per il semplice fatto che gli Stati, anche quando si trovano d’accordo sul valore da porre a base del riconoscimento, divergono poi (il più delle volte per ragioni politiche) sulla sua riscontrabilità in ciascun caso concreto.
Se, quindi, i requisiti necessari affinché lo Stato acquisti (automaticamente) la personalità internazionale sono quelli dell’effettività e dell’indipendenza, resta da chiedersi se essi siano anche sufficienti o se ne occorrano altri. Tralasciando le evidenti esagerazioni delle già citate Dichiarazioni di Bruxelles (che contengono una lunga lista di requisiti che non trova precedenti nella prassi), sarà sufficiente in questa sede limitarsi ai requisiti che oggi più frequentemente ricorrono, e cioè che lo Stato nuovo non costituisca una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, goda del consenso del popolo – espresso tramite libere elezioni – e non violi i diritti umani. Può effettivamente dirsi che non siano da considerare come soggetti internazionali gli Stati che tengano comportamenti del genere? La risposta è da ritenersi negativa. In realtà, tali requisiti, se considerati non come requisiti ai quali uno Stato pre-esistente subordina l’instaurazione di rapporti di amicizia con uno Stato nuovo, ma come presupposti della personalità internazionale – e quindi come presupposti che devono sussistere non solo affinché la personalità si acquisti, ma affinché essa non si perda – non trovano alcun riscontro nella realtà. Stati che, permanentemente o temporaneamente, minacciano la pace o sono autoritari o violano i diritti umani non mancano nella comunità internazionale. E non sono neppure pochi. Anzi, a ben guardare, costituiscono larga maggioranza. Ma non è tutto: se è sicuramente vero che, secondo sicuri principi del diritto internazionale contemporaneo, uno Stato è obbligato a non minacciare la pace e a rispettare i diritti umani, è altrettanto vero che simili obblighi, in quanto tali, non condizionano ma, anzi, presuppongono e, in ultima analisi, contribuiscono a definire la personalità giuridica dello Stato medesimo.
NOTE:
[1] Tale concezione solleva diversi dubbi, per esempio, sulla classificazione giuridica dell’Iraq, la cui Costituzione è stata de facto imposta dall’occupante statunitense e, addirittura, scritta in inglese per poi essere tradotta in arabo, con tutte le difficoltà e le incongruenze della traduzione.
[2] Governi fantoccio, come tali privi di soggettività internazionale, si ebbero ad esempio durante la 2nda GM nei territori occupati dai Nazisti (Governo Quisling in Norvegia, Repubblica sociale italiana, etc.). Un esempio attuale di Governo fantoccio è da molti considerato quello della Repubblica turco-cipriota, insediata dalle forze militari turche nella parte settentrionale di Cipro e controllata dalla stessa Turchia. Di questo avviso è in particolare la Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. del 18/12/1996 nel caso Loizidou c. Turchia) che ritiene responsabile la Turchia per la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo perpetrate in quel territorio. Nello specifico, secondo la Corte, “Non occorre accertare se…la Turchia eserciti nel dettaglio un controllo sulla politica e sulle azioni delle autorità della Repubblica turca di Cipro del Nord. Il gran numero di soldati [turchi] che partecipano a missioni attive nel Nord di Cipro…attesta che l’esercito turco ha in pratica un controllo globale di questa parte dell’isola…Tale controllo implica la responsabilità della Turchia in ragione della politica e delle azioni della Repubblica” (par.44).
[3] L’irrilevanza del riconoscimento (e del non-riconoscimento) sull’esistenza dello Stato è efficacemente messa in luce in una sentenza della Corte d’appello degli Stati Uniti (2° circuito, 24/01/1992, New York Chinese TV Programs Inc. v. UE Enterprises Inc., ILR, vol.96, 81ss., partic.88). La Corte si rifiuta di considerare come estinto – per estinzione di uno dei soggetti contraenti – un trattato tra Usa e Taiwan, Stato non più riconosciuto dai primi dopo il 1979 ma, a giudizio della Corte, ancora dotato degli attributi statali. La sentenza contiene anche un riferimento ai trattati tra Usa e altri Stati, come Iran e Cuba, da essi non riconosciuti.
[4] Più approfonditamente, il riconoscimento può essere espresso (dichiarato formalmente), tacito (ricavabile da fatti concludenti, come l’instaurazione di relazioni diplomatiche), de facto (provvisorio e limitato ad alcuni rapporti giuridici, come in caso di instabilità del nuovo Stato), de jure (definitivo e pieno), di Stati (relativo ad un nuovo Stato) o di Governi (relativo ad un Governo rivoluzionario di uno Stato pre-esistente).
[5] Un’importante distinzione si ha, a tal proposito, tra teoria del valore costitutivo (bilaterale o unilaterale) e teoria del valore dichiarativo. Fonti del primo caso sono: Trattato di pace di Parigi del 30/03/1856 (art.7); Dichiarazioni di Bruxelles del 16/12/1991 (cfr. nota 7). Fonti del secondo caso sono invece: risoluzione dell’Institut de droit international del 23/04/1936 sul riconoscimento degli Stati e dei Governi; sentenza della Corte di Cassazione italiana del 25/06/1985 n.1981 sul caso Yesser Arafat; parere n.10 del 04/07/1992 della Commissione arbitrale mista istituita dalla Conferenza di pace sulla Jugoslavia.
[6] Ciò è particolarmente vero per i cd. riconoscimento di Stati e di Governi: se si ritiene che lo Stato quale soggetto internazionale si identifichi con lo Stato-organizzazione (il complesso degli organi statali) ne consegue che il riconoscimento di Stati e quello di governi rivoluzionari coincidono (se cambia radicalmente il governo di uno Stato, cambia anche lo Stato stesso come soggetto internazionale, e il riconoscimento del nuovo governo equivale allora al riconoscimento del nuovo Stato); se invece si accoglie una diversa nozione di Stato quale soggetto internazionale (come ad esempio quella tridimensionalistica che lo configura come ‘ente ternario’ o insieme di 3 elementi – popolo, territorio e sovranità su di essi) si accetta la distinzione tra riconoscimento di Stati e riconoscimento di Governi, ossia la possibilità che l’uno non implichi necessariamente l’altro.