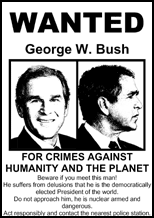Quanti altri morti, per sentirvi cittadini di Gaza?
E leggerò sui vostri giornali, domani, che tutto questo è solo un attacco preventivo, solo legittimo, inviolabile diritto di autodifesa. La quarta potenza militare al mondo, i suoi muscoli nucleari contro razzi di latta, e cartapesta e disperazione. E mi sarà precisato naturalmente, che no, questo non è un attacco contro i civili - e d'altra parte, ma come potrebbe mai esserlo, se tre uomini che chiacchierano di Palestina, qui all'angolo della strada, sono per le leggi israeliane un nucleo di resistenza, e dunque un gruppo illegale, una forza combattente? - se nei documenti ufficiali siamo marchiati come entità nemica, e senza più il minimo argine etico, il cancro di Israele? Se l'obiettivo è sradicare Hamas - tutto questo rafforza Hamas. Arrivate a bordo dei caccia a esportare la retorica della democrazia, a bordo dei caccia tornate poi a strangolare l'esercizio della democrazia - ma quale altra opzione rimane? Non lasciate che vi esploda addosso improvvisa. Non è il fondamentalismo, a essere bombardato in questo momento, ma tutto quello che qui si oppone al fondamentalismo. Tutto quello che a questa ferocia indistinta non restituisce gratuito un odio uguale e contrario, ma una parola scalza di dialogo, la lucidità di ragionare il coraggio di disertare - non è un attacco contro il terrorismo, questo, ma contro l'altra Palestina, terza e diversa, mentre schiva missili stretta tra la complicità di Fatah e la miopia di Hamas. Stava per assassinarmi per autodifesa, ho dovuto assassinarlo per autodifesa - la racconteranno così, un giorno i sopravvissuti.
E leggerò sui vostri giornali, domani, che è impossibile qualsiasi processo di pace, gli israeliani, purtroppo, non hanno qualcuno con cui parlare. E effettivamente - e ma come potrebbero mai averlo, trincerati dietro otto metri di cemento di Muro? E soprattutto - perché mai dovrebbero averlo, se la Road Map è solo l'ennesima arma di distrazione di massa per l'opinione pubblica internazionale? Quattro pagine in cui a noi per esempio, si chiede di fermare gli attacchi terroristici, e in cambio, si dice, Israele non intraprenderà alcuna azione che possa minare la fiducia tra le parti, come - testuale - gli attacchi contro i civili. Assassinare civili non mina la fiducia, mina il diritto, è un crimine di guerra non una questione di cortesia. E se Annapolis è un processo di pace, mentre l'unica mappa che procede sono qui intanto le terre confiscate, gli ulivi spianati le case demolite, gli insediamenti allargati - perché allora non è processo di pace la proposta saudita? La fine dell'occupazione, in cambio del riconoscimento da parte di tutti gli stati arabi. Possiamo avere se non altro un segno di reazione? Qualcuno, lì, per caso ascolta, dall'altro lato del Muro?
Ma sto qui a raccontarvi vento. Perché leggerò solo un rigo domani, sui vostri giornali e solo domani, poi leggerò solo, ancora, l'indifferenza. Ed è solo questo che sento, mentre gli F16 sorvolano la mia solitudine, verso centinaia di danni collaterali che io conosco nome a nome, vita a vita - solo una vertigine di infinito abbandono e smarrimento. Europei, americani e anche gli arabi - perché dove è finita la sovranità egiziana, al varco di Rafah, la morale egiziana, al sigillo di Rafah? - siamo semplicemente soli. Sfilate qui, delegazione dopo delegazione - e parlando, avrebbe detto Garcia Lorca, le parole restano nell'aria, come sugheri sull'acqua. Offrite aiuti umanitari, ma non siamo mendicanti, vogliamo dignità libertà, frontiere aperte, non chiediamo favori, rivendichiamo diritti. E invece arrivate, indignati e partecipi, domandate cosa potete fare per noi. Una scuola? Una clinica forse? Delle borse di studio? E tentiamo ogni volta di convincervi - no, non la generosa solidarietà, insegnava Bobbio, solo la severa giustizia - sanzioni, sanzioni contro Israele. Ma rispondete - e neutrali ogni volta, e dunque partecipi dello squilibrio, partigiani dei vincitori - no, sarebbe antisemita. Ma chi è più antisemita, chi ha viziato Israele passo a passo per sessant'anni, fino a sfigurarlo nel paese più pericoloso al mondo per gli ebrei, o chi lo avverte che un Muro marca un ghetto da entrambi i lati? Rileggere Hannah Arendt è forse antisemita, oggi che siamo noi palestinesi la sua schiuma della terra, è antisemita tornare a illuminare le sue pagine sul potere e la violenza, sull'ultima razza soggetta al colonialismo britannico, che sarebbero stati infine gli inglesi stessi? No, non è antisemitismo, ma l'esatto opposto, sostenere i tanti israeliani che tentano di scampare a una nakbah chiamata sionismo. Perché non è un attacco contro il terrorismo, questo, ma contro l'altro Israele, terzo e diverso, mentre schiva il pensiero unico stretto tra la complicità della sinistra e la miopia della destra.
So quello che leggerò, domani, sui vostri giornali. Ma nessuna autodifesa, nessuna esigenza di sicurezza. Tutto questo si chiama solo apartheid - e genocidio. Perché non importa che le politiche israeliane, tecnicamente, calzino oppure no al millimetro le definizioni delicatamente cesellate dal diritto internazionale, il suo aristocratico formalismo, la sua pretesa oggettività non sono che l'ennesimo collateralismo, qui, che asseconda e moltiplica la forza dei vincitori. La benzina di questi aerei è la vostra neutralità, è il vostro silenzio, il suono di queste esplosioni. Qualcuno si sentì berlinese, davanti a un altro Muro. Quanti altri morti, per sentirvi cittadini di Gaza?
Mustafa Barghouti (ex ministro dell'informazione del governo di unità nazionale palestinese) Ramallah, 27 dicembre 2008.











 Radovan Karadzic
Radovan Karadzic