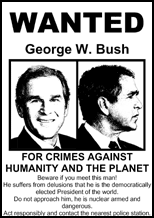Il saccheggio del Congo
Etichette:
AFRICA
 1. La storia della Repubblica Democratica del Congo – l’ex Zaire, un paese grande come un quarto dell'Europa - è segnata da numerosi conflitti finalizzati spesso al controllo delle immense risorse naturali di cui dispone: oro, diamanti, uranio, cobalto, rame e coltan (columbite-tantalite, metallo utilizzato nella telefonia cellulare e per le componenti informatiche), legno pregiato e gomma arabica. Ricchezze delle quali i congolesi non hanno mai usufruito: sfruttato prima dalla colonizzazione belga, poi dalla trentennale dittatura di Sese Seko Mobutu (1965-1997) quindi, a partire dagli anni '90, invaso dagli eserciti dei paesi vicini e da bande mercenarie che hanno sostenuto e alimentato la guerra civile e gli scontri tra le componenti etniche delle province frontaliere. Il conflitto in corso nella Repubblica Democratica del Congo è il più sanguinoso dai tempi della Seconda guerra mondiale e, anche a causa del gran numero di eserciti dei paesi limitrofi che ha coinvolto, è stato definito "Guerra mondiale africana". Nonostante i primi accordi di pace firmati nel 1999, i conflitti hanno avuto il loro apice tra il 1998 e il 2002, causando oltre 3,3 milioni di morti e circa 3 milioni di sfollati.
1. La storia della Repubblica Democratica del Congo – l’ex Zaire, un paese grande come un quarto dell'Europa - è segnata da numerosi conflitti finalizzati spesso al controllo delle immense risorse naturali di cui dispone: oro, diamanti, uranio, cobalto, rame e coltan (columbite-tantalite, metallo utilizzato nella telefonia cellulare e per le componenti informatiche), legno pregiato e gomma arabica. Ricchezze delle quali i congolesi non hanno mai usufruito: sfruttato prima dalla colonizzazione belga, poi dalla trentennale dittatura di Sese Seko Mobutu (1965-1997) quindi, a partire dagli anni '90, invaso dagli eserciti dei paesi vicini e da bande mercenarie che hanno sostenuto e alimentato la guerra civile e gli scontri tra le componenti etniche delle province frontaliere. Il conflitto in corso nella Repubblica Democratica del Congo è il più sanguinoso dai tempi della Seconda guerra mondiale e, anche a causa del gran numero di eserciti dei paesi limitrofi che ha coinvolto, è stato definito "Guerra mondiale africana". Nonostante i primi accordi di pace firmati nel 1999, i conflitti hanno avuto il loro apice tra il 1998 e il 2002, causando oltre 3,3 milioni di morti e circa 3 milioni di sfollati.Keith Harmon Snow, un investigatore indipendente per i diritti umani e corrispondente di guerra per le organizzazioni Survivors Rights International e Genocide Watch e per le Nazioni Unite, ha recentemente riferito che nell'ottobre del 1996 ci sono stati almeno 1,5 milioni di rifugiati ruandesi e del Burundi nello Zaire orientale [Congo]. L'invasione a tutta scala è iniziata più formalmente quando le forze delegate dalla Rwandan Patriotic Army e dalla Ugandan Patriotic Defense bombardarono con l'artiglieria i campi profughi, uccidendo centinaia di migliaia di persone in un “chiaro caso di genocidio”. Il medesimo rapporto faceva anche notare che il numero di morti in Congo ha raggiunto livelli paragonabili a quelli del genocidio voluto dal re belga Leopoldo in Congo più di 100 anni prima, con “oltre 10 milioni di morti in Congo dal 1996, e milioni in più in Uganda e Rwanda”. Esso ha definito le morti come “ prodotti delle amministrazioni Bush-Clinton-Bush” (Keith Harmon Snow, The War that did not make the Headlines: Over Five Million Dead in Congo? Global Research: January 31, 2008).
Nell'aprile del 2001 il membro del Congresso Cynthia McKinney tenne un'udienza sul coinvolgimento occidentale nel saccheggio dell'Africa, in cui affermava che “al cuore della sofferenza dell'Africa c'è il desiderio dell'Occidente, e soprattutto degli Stati Uniti, di accedere ai diamanti, al petrolio, al gas naturale e ad altre preziose risorse africane... l'Occidente, e in particolare gli Stati Uniti, hanno messo in moto una politica di oppressione, destabilizzazione motivata, non da principi morali, ma da uno spietato desiderio di arricchirsi con le favolose ricchezze dell'Africa” (John Perkins, The Secret History of the American Empire, Penguin Group, New York, 2007). Sembrerebbe quasi che re Leopoldo II sia tornato in Congo. Ma se ne era mai andato?
2. A parte la complessità e la carenza di informazioni documentabili, è evidente – basta semplicemente dare uno sguardo sommario alle parti combattenti – che si tratta del classico conflitto ‘per procura’, in cui potenze esterne fanno il doppio gioco con lo scopo di cristallizzare l’instabilità del paese e poter, così, gestire i loro affari: 1997/2002 - guerriglieri Tutsi del Raggruppamento Congolese per la Democrazia (Rcd), appoggiati dal Ruanda, e del Movimento di Liberazione del Congo (Mlc), sostenuto dall'Uganda, contro il governo di Laurent Kabila (dal 2001 di suo figlio Joseph), appoggiato dagli eserciti di Angola, Namibia e Zimbabwe, nonché da varie milizie filo-governative (Mayi-Mayi e Hutu Interahamwe); 1999/2003 - scontri tra le fazioni rivali in cui si è diviso nel 1999 l'RCD, ovvero l'RCD-Goma (sostenuto dal Ruanda) e l'RCD-Kisangani ("ammutinati" sostenuti dall'Uganda); 1999/2005 - milizie degli Hema dell’Unione dei Patrioti Congolesi (Upc) contro milizie Lendu del Fronte Nazionalista Integrazionista (Fni) nella regione nord-orientale dell'Ituri. Ulteriore elemento della vastità degli interessi esteri in gioco, il fatto che il governo abbia ricevuto armi da Stati Uniti, Francia, Cina, Corea del Nord, Georgia, Polonia, altri Paesi dell'Europa dell'ex blocco sovietico (oltre che il diretto sostegno militare di Angola, Namibia e Zimbabwe), mentre i guerriglieri dell'Rcd dal Ruanda, quelli dell'Mlc dall'Uganda. La solita sporca storia.
Dopo l'assassinio di Laurent Kabila nel 2001, il figlio Joseph ha avviato nel 2002 il processo di pace (dialogo intercongolese, tenutosi in Sudafrica) che ha portato al ritiro degli eserciti stranieri alleati del governo (Angola, Namibia e Zimbabwe) e di quelli che sostenevano i ribelli (Ruanda e Uganda). Nonostante questo la presenza di milizie nelle regioni orientali del Paese resta considerevole, e nel Kivu si registrano sporadici scontri tra gli uomini del Rcd-Goma e le milizie Mayi-Mayi, che operano anche nel Katanga con attacchi frequenti alle truppe regolari congolesi. La presenza dei ribelli Hutu delle Fdlr (Forze Democratiche di Liberazione del Ruanda), sostenute durante la guerra dal governo congolese, è un ulteriore fattore di instabilità per la regione. Dalla primavera del 2005 le Fdlr hanno rinunciato ufficialmente alla lotta armata, ma il programma di disarmo e rimpatrio non è ancora cominciato. In Kivu si registrano periodicamente movimenti di truppe a cui non sarebbero estranei contingenti militari del Ruanda, più volte accusato di destabilizzare la regione. Le truppe del Rcd-Goma, che in seguito all'accordo di pace sono entrate a far parte dell'esercito nazionale, sono sospettate di avere ancora legami molto stretti con le autorità ruandesi, tanto che dal 2003 vi sono stati numerosi casi di ammutinamento tra i contingenti militari appartenenti all'ex-gruppo ribelle. Il più famoso tra questi gruppi di dissidenti è quello capeggiato dal generale Laurent Nkunda, che nel 2004 è riuscito a occupare per diversi giorni la città di Bukavu impegnando severamente l’esercito e i caschi blu della Monuc, la missione Onu nel Paese. I dissidenti di Nkunda sono poi tornati a colpire nel gennaio 2006, quando per alcuni giorni hanno occupato la città di Rushturu e altri centri abitati minori nelle circostanze. La Monuc tenta con scarso successo di stabilizzare la situazione, anche perché i dissidenti sconfinano spesso in Ruanda per sfuggire alla cattura.
Nella primavera del 2005 c'è stata una recrudescenza del conflitto in Ituri, regione che negli anni precedenti non era stata toccata dal programma di disarmo. I frequenti scontri tra le milizie che si contendono il territorio hanno causato centinaia di vittime e hanno provocato la fuga di milioni di persone. La Monuc ha conseguentemente avviato un programma di smantellamento forzato delle circa sette milizie che si fronteggiavano nella regione. L'operazione è sostanzialmente riuscita, visto che la maggior parte dei capi miliziani è stata arrestata e imprigionata, ma gli scontri nella regione continuano anche se con minore intensità. Un ulteriore fattore di destabilizzazione è costituito dai ribelli ugandesi del Lra (Lord’s Resistance Army) che dalle loro basi nel sud del Sudan sconfinano spesso nel Congo settentrionale, attaccando la popolazione in cerca di soldi e viveri. A inizio 2006 la Monuc si è scontrata più volte con i ribelli.
3. Il mese scorso, Jean-Pierre Bemba Gombo, ex vice-Presidente e maggiore leader dell’opposizione dopo le ultime elezioni del 2006, che consegnarono il Paese all’attuale Presidente Joseph Kabila, è stato arrestato a Bruxelles sabato notte. L’ordine di arresto è arrivato dalla Corte Penale Internazionale, per richiesta del Procuratore Moreno-Ocampo. L’ex leader del Movimento per la Liberazione del Congo (MLC) è accusato di aver commesso crimini di guerra e contro l’umanità nella Repubblica Centrafricana tra l’ottobre del 2002 ed il marzo del 2003. Nello specifico le accuse sono di stupro e tortura per quanto riguarda i crimini contro l’umanità, cui si aggiungono quelle che riguardano i crimini di guerra: oltre i due reati precedenti, vi è l’offesa alla dignità umana (trattamenti umilianti e degradanti) e il saccheggio di villaggi. Bemba aveva lasciato la Repubblica Democratica del Congo l’anno scorso, temendo per la sua vita dopo che le sue milizie erano state coinvolte in violenti scontri interni, e si era rifugiato con la sua famiglia in Portogallo. Attualmente l’ex Comandante del MLC è il primo arrestato nell’ambito dell’inchiesta della Corte Penale Internazionale sui crimini di guerra nella Repubblica Centrafricana, iniziata nel 2007. Lo stesso Tribunale Internazionale, con sede all’Aja, sta indagando anche su altri fatti di guerra in Paesi africani, come l’Uganda, la stessa Repubblica Democratica del Congo e il Sudan (per i crimini legati al conflitto in Darfur).
L’arresto di Jean-Pierre Bemba a Bruxelles, per ordine di autorità belghe, pone nuovamente il dibattito sulla responsabilità dei processi penali per crimini di guerra. Il Tribunale Penale Internazionale, attivo dal 2002, dovrebbe essere l’organo preposto dalle Nazioni Unite a giudicare questo tipo di reati, ma più volte si è posta la questione della riluttanza di alcuni Paesi (Stati Uniti in testa) a consegnare propri concittadini al Tribunale olandese. Si ripropone anche la questione dei rapporti dei Paesi africani con quelli europei, in particolar modo gli ex colonizzatori. Al momento il governo di Kinshasa ha richiamato il proprio ambasciatore a Bruxelles, creando i presupposti per una crisi diplomatica. Crisi, peraltro, già aperta recentemente, da quando il Ministro degli Esteri belga Karel De Gucht ha accusato la RDC di corruzione e violazione dei diritti umani, oltre che dei suoi rapporti con la Cina. Proprio il gigante asiatico sta diventando il partner privilegiato dei governi dell’Africa centrale, a discapito degli alleati storici, come Francia e Belgio. L’arresto di Bemba pone infatti l’accento su una distinzione fondamentale tra l’Europa e la Cina nei confronti dei Paesi africani, dal momento che Pechino, almeno fino ad ora, non ha mai vincolato i legami politico-economici al rispetto dei diritti umani e dei principi democratici.
APPROFONDIMENTI:
- FURTO DI STATO (puntata di Report dedicata ad un materiale strategico ed ambitissimo, il coltan (o tantalio), di cui la RDC è primo produttore mondiale).
- L'equilibrio instabile del Congo, Affari internazionali, 17/06/2008.
- Kabila si riprende il Congo, Altrenotizie, 17/11/2006.
- Congo, la vittoria annunciata, Altrenotizie, 04/08/2006.
- Congo, prove di democrazia, Altrenotizie, 04/04/2006.