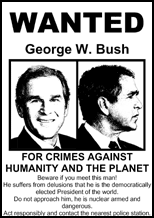Shoah si, Nakba no: quando la memoria è discriminante
Etichette:
GREATER MIDDLE EAST
Partiamo da un presupposto: la Shoah è stata una cosa orribile, nessuno può negare i fatti ed è importante non dimenticare. Il sonno della ragione genera mostri. Ma nei giorni della 'memoria' (come sono comunemente definiti) io voglio ricordare anche un altro sterminio, uno di quelli non pubblicizzati seppur non appartenga alla storia, dal momento che è, invece, di estrema attualità.
Perché non è possibile usare due pesi e due misure, non è possibile dire e far vedere solo quello che conviene. Perché l'olocausto deve, giustamente, essere ricordato e la Nakba (come viene definito quello palestinese - tutt'ora in corso) no?
Lo spunto viene, questa volta, da una figura super partes come il nostro Presidente della Repubblica. "No all'antisemitismo (e fin qui siamo d'accordo) anche quando esso si travesta da antisionismo [che] significa negazione della fonte ispiratrice dello stato ebraico, delle ragioni della sua nascita, ieri, e della sua sicurezza oggi, al di là dei governi che si alternano alla guida di Israele".
A parte l'ultima e inaccettabile "...al di là dei governi che si alternano..." (che cos'è una forma di giustificazione? Quindi, se in Israele si "alterna" un governo che pratica crimini orribili può tranquillamente farlo senza temere niente?) vorrei ricordare - perché è questo che sto tentando di fare - che cosa è il sionismo, come e quando è nato, come si è sviluppato, a cosa ha dato vita.
Di fronte all'evidente faziosità dei media, è necessario, infatti, che qualcuno ricordi tutto questo.
Perché giornalmente sentiamo parlare di terrorismo palestinese - tanto che ormai è diventato un termine unico ed inscindibile - e non si sente MAI parlare di terrorismo sionista? Perché è lecito disprezzare la causa palestinese - tanto che é nata una nuova cultura, quella dell'islamofobia - e non si possono criticare gli ebrei, anche quando commettono crimini ugualmente deprecabili al pari dell'olocausto, senza essere accusati di antisemitismo? Tanto più che semiti non sono solo gli ebrei, ma tutte quelle popolazioni di una certa area del medioriente che parlano lingue diverse appartenenti allo stesso ceppo.
Come ha detto il portavoce della comunità ebraica romana Riccardo Pacifici, il discorso di Napolitano è "un passaggio che fa fare un grande passo in avanti nel ristabilire giustizia e verità nei confronti della storia e di coloro che molto spesso usano l'antisionismo come moderno strumento di antisemitismo".
Se lui può dire questo, allora io rivendico il mio diritto di dire che l'olocausto viene usato strumentalmente dal regime sionista per giustificare lo sterminio dei palestinesi, che va avanti da 80 anni con il colpevole e compiacente silenzio di tutto il mondo (proprio come accadde durante lo scempio nazista). E' necessario rivendicare questo diritto per ristabilire giustizia e verità nei confronti della storia. Me ne frego del decreto Mastella (tra l'altro ben lungi da me incitare alla violenza e alla discriminazione, propongo solo una verità storica oggigiorno celata) perché me lo permette l'articolo 21 della Costituzione. E nessuno mi venga a dire che il Costituente è sullo stesso piano di un ministro bigotto ed insignificante, un 'grillo' della politica che salta qua e là per occupare poltrone, del quale è impossibile nutrire la benché minima stima.
Nel prossimo post, allora, trovate tutta la verità sulla "fonte ispiratrice dello stato ebraico". Perché nessuno dimentichi e nessuno dica "io non lo sapevo".