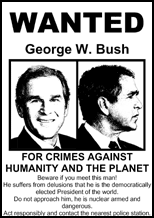La caduta
Etichette:
VIGNETTE-PHOTOGALLERY-IMMAGINI
Pubblicato da
KATU
0
commenti
![]()
Pubblicato da
KATU
0
commenti
![]()
 Poco più di un anno fa (26 dicembre 2006) l’esecuzione di Saddam Hussein gettava ombre sul processo di pacificazione dell’Iraq. Da allora è sempre più evidente il fallimento di una non dichiarata strategia della vendetta. Dalla ventilata “svolta epocale”, all'”uccisione per procura” decisa dal grottesco remake di Norimberga.
Poco più di un anno fa (26 dicembre 2006) l’esecuzione di Saddam Hussein gettava ombre sul processo di pacificazione dell’Iraq. Da allora è sempre più evidente il fallimento di una non dichiarata strategia della vendetta. Dalla ventilata “svolta epocale”, all'”uccisione per procura” decisa dal grottesco remake di Norimberga.
Pubblicato da
KATU
0
commenti
![]()

 La comunità di lingua fiamminga (vista da sempre come la lingua dei contadini) vive nelle Fiandre, regione una volta povera e cattolica, ora molto ricca e in continua crescita economica grazie, soprattutto all'industria e alla tecnologia. Da sempre i fiamminghi hanno mal digerito la penetrazione culturale e linguistica francese (basti pensare - lo dico per esperienza personale - che nella finale mondiale del 2006 tra Francia e Italia erano tutti dalla nostra parte) e hanno pian piano reagito a questa situazione, arrivando negli ultimi anni a cambiare tutti i cartelli stradali, a vietare le scritte in francese sulle vetrine dei negozi o sui mezzi di trasporto pubblici, fino ad istituire scuole che impartiscono la didattica esclusivamente in fiammingo - la lingua francese è studiata al pari delle altre come lingua straniera). E' interessante notare che in territorio fiammingo, precisamente a 50 km ad est di Bruxelles, esiste una città, Leuven (in cui si parla fiammingo), all'interno della quale è stata costruita una cittadella universitaria, Louvaine la Nouve (la nuova, appunto) in cui si insegna in francese. L'istituto - che ho personalmente visitato - ha la biblioteca di studi mediorientali più grande d'Europa e i libri al suo interno sono divisi tra quelli in fiammingo (contrassegnati da numeri dispari) e quelli in francese (numeri pari). Anche la consultazione avviene in stanze separate.
La comunità di lingua fiamminga (vista da sempre come la lingua dei contadini) vive nelle Fiandre, regione una volta povera e cattolica, ora molto ricca e in continua crescita economica grazie, soprattutto all'industria e alla tecnologia. Da sempre i fiamminghi hanno mal digerito la penetrazione culturale e linguistica francese (basti pensare - lo dico per esperienza personale - che nella finale mondiale del 2006 tra Francia e Italia erano tutti dalla nostra parte) e hanno pian piano reagito a questa situazione, arrivando negli ultimi anni a cambiare tutti i cartelli stradali, a vietare le scritte in francese sulle vetrine dei negozi o sui mezzi di trasporto pubblici, fino ad istituire scuole che impartiscono la didattica esclusivamente in fiammingo - la lingua francese è studiata al pari delle altre come lingua straniera). E' interessante notare che in territorio fiammingo, precisamente a 50 km ad est di Bruxelles, esiste una città, Leuven (in cui si parla fiammingo), all'interno della quale è stata costruita una cittadella universitaria, Louvaine la Nouve (la nuova, appunto) in cui si insegna in francese. L'istituto - che ho personalmente visitato - ha la biblioteca di studi mediorientali più grande d'Europa e i libri al suo interno sono divisi tra quelli in fiammingo (contrassegnati da numeri dispari) e quelli in francese (numeri pari). Anche la consultazione avviene in stanze separate.
 Ma c'è un'altra comunità linguistica, quella germanofona che vive in quei territori di frontiera con la Germania - territori restituiti al Belgio con il Trattato di Versailles del 1919 - che ha tutto il vantaggio a proseguire per la sua strada senza invischiarsi nella questione (amministrativamente quest'area fa parte della Vallonia). Grazie all'ampia autonomia concessale per via della lingua, riceve enormi finanziamenti che vanno ad accelerarne la crescita e la ricchezza, tanto che non pensa minimamente a reclamare il ritorno alla Germania, della quale costituirebbe solo una remota area periferica e sarebbe, dunque, destinata a tutt'altro livello di vita.
Ma c'è un'altra comunità linguistica, quella germanofona che vive in quei territori di frontiera con la Germania - territori restituiti al Belgio con il Trattato di Versailles del 1919 - che ha tutto il vantaggio a proseguire per la sua strada senza invischiarsi nella questione (amministrativamente quest'area fa parte della Vallonia). Grazie all'ampia autonomia concessale per via della lingua, riceve enormi finanziamenti che vanno ad accelerarne la crescita e la ricchezza, tanto che non pensa minimamente a reclamare il ritorno alla Germania, della quale costituirebbe solo una remota area periferica e sarebbe, dunque, destinata a tutt'altro livello di vita.
Pubblicato da
KATU
2
commenti
![]()
 E' morto il 20 novembre scorso ad 88 anni Ian Douglas Smith, ex-primo ministro della Rhodesia (l'odierno Zimbabwe) considerato da molti il simbolo dell'epoca colonialista e razzista dell'Africa. Per 15 anni alla guida del paese dal 1964 al 1979, aveva unilateralmente proclamato l'indipendenza dalla Gran Bretagna l'anno successivo (dichiarazione mai riconosciuta a livello internazionale che provocò una sanguinosa guerra civile), ribattezzando il paese Repubblica di Rhodesia [storia]. L'indipendenza vera e propria fu raggiunta grazie alla maggioranza nera solo nel 1980, e questa volta ottenne il riconoscimento internazionale. Da allora il nome dello stato è Zimbabwe [storia], nome che deriva dalla parola shona Zimba Remabwe, il cui significato è 'grande casa di pietra'.
E' morto il 20 novembre scorso ad 88 anni Ian Douglas Smith, ex-primo ministro della Rhodesia (l'odierno Zimbabwe) considerato da molti il simbolo dell'epoca colonialista e razzista dell'Africa. Per 15 anni alla guida del paese dal 1964 al 1979, aveva unilateralmente proclamato l'indipendenza dalla Gran Bretagna l'anno successivo (dichiarazione mai riconosciuta a livello internazionale che provocò una sanguinosa guerra civile), ribattezzando il paese Repubblica di Rhodesia [storia]. L'indipendenza vera e propria fu raggiunta grazie alla maggioranza nera solo nel 1980, e questa volta ottenne il riconoscimento internazionale. Da allora il nome dello stato è Zimbabwe [storia], nome che deriva dalla parola shona Zimba Remabwe, il cui significato è 'grande casa di pietra'.
Pubblicato da
KATU
0
commenti
![]()

Pubblicato da
KATU
0
commenti
![]()
 Il 2008 è appena cominciato e, come ogni inizio di nuovo anno, ci si aspettano novità e si guarda ai prossimi 12 mesi con curiosità. Ma, come sempre, c'è chi rilancia le sue crociate in difesa di non meglio specificati valori con il tentativo di indirizzare ed influire sulla politica del paese. Insomma, la solita storia.
Il 2008 è appena cominciato e, come ogni inizio di nuovo anno, ci si aspettano novità e si guarda ai prossimi 12 mesi con curiosità. Ma, come sempre, c'è chi rilancia le sue crociate in difesa di non meglio specificati valori con il tentativo di indirizzare ed influire sulla politica del paese. Insomma, la solita storia.
Pubblicato da
KATU
0
commenti
![]()