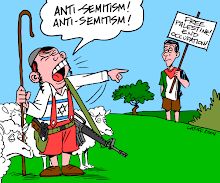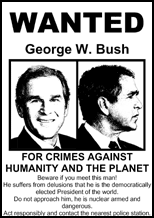cartina di limes on line
cartina di limes on lineDalle elezioni in Pakistan emergono alcuni chiari dati che è il caso di sottolineare. La bassa affluenza alle urne, leggermente inferiore rispetto a quella del 2002, conferisce al voto una non piena legittimità, anche se le elezioni possono essere giudicate abbastanza libere e trasparenti. Gli episodi di violenza e di intimidazione sono stati limitati, e il fatto è dimostrato anche dai risultati, che danno al Partito Popolare Pachistano (PPP) e alla Lega Musulmana di Sharif (PML-N) una netta vittoria. Pochi, invece, i voti per il partito pro-Musharraf, la Lega Musulmana-Q, con lo stesso presidente della PML-Q, Chadhry Shujat Hussein, sconfitto addirittura da un candidato del PPP. Infine, sembrano significativi l'alto numero di candidati indipendenti eletti - una variabile di cui tenere conto nella formazione del nuovo governo - e l'avanzata dei partiti regionali su base etnica a scapito della coalizione di partiti religiosi (effetto in parte della decisione del jamaat-e- islami, membro influente della coalizione, di boicottare il voto). Si profila quindi una situazione in cui Musharraf, in qualità di presidente, dovrà lavorare con un parlamento ostile.
In generale, pur nel quadro di una tendenziale conferma delle previsioni della vigilia (ovvero l'affermazione dei partiti di opposizione e la sconfitta del PML-Q), nessuno dei partiti maggiori ha riportato una vittoria schiacciante. Ciò costituisce, almeno in parte, una sorpresa date le diffuse aspettative di vittoria del PPP, e la prevista ondata emotiva causata dall'assassinio di Benazir Bhutto. Infatti, i leader del PPP hanno subito accusato il governo di avere in qualche modo limitato il successo del partito, almeno in alcuni collegi, oltre a non aver permesso alcune candidature. Vero è che il panorama successivo al voto, pur nel quadro dell'affermazione del PPP e del PML-N, risulta molto frammentato, e questo costituisce una buona notizia per i militari: l'esercito pachistano – in qualche modo vero detentore del potere - almeno a partire dalla seconda metà degli anni sessanta, ha puntato esattamente su queste condizioni di frammentazione della politica, sperando di agire da ‘political broker’.
È interessante notare che il PPP è l'unico partito a base realmente nazionale. Si può dire che si sia de-localizzato, ridimensionando il suo carattere regionale sindhi-rurale; mentre, al contrario, il PML-N si è molto regionalizzato, trincerandosi nella sua roccaforte panjabi (ciò benché abbia avuto un buon successo in parte della Frontiera). Si può dire si sia invertita la tendenza delle elezioni del 1997, quando il PPP era diventato in pratica un partito sindhi, mentre la PML di Nawaz aveva vinto in diverse province; il che conferma il carattere fluido della politica pachistana. Interessante è anche la situazione dei partiti religiosi, benché forse maggiori informazioni siano necessarie. Certamente, traspare la perdita di influenza del Muttahida Majlis-i-Amal nelle province di frontiera, anche se le ragioni sono forse più complesse di quanto sembri. Un'ostilità dell'elettorato verso l'influenza degli islamisti nella regione può essere connessa non solo con la questione della lotta al terrorismo, ma anche più semplicemente con una insoddisfazione verso l'amministrazione quotidiana della provincia (spesso molto ideologizzata). In ogni caso, è prematuro concludere che i partiti religiosi siano scomparsi dalla regione, dato che conservano una loro influenza. Probabilmente i partiti religiosi pagano anche una proliferazione di organizzazioni di ispirazione islamista, che ha reso il quadro molto confuso.
In conclusione, si può affermare che le prospettive di ricostruzione del quadro politico siano incerte. Benché sia stato trovato un accordo per formare un governo di coalizione PPP-PML(N), questo si presenta come fragile sia per le distanze (e la reciproca diffidenza) tra le due leadership, sia perchè entrambi i partiti sanno bene che nessun futuro governo pachistano può seriamente pensare di fare a meno dell'appoggio dell'esercito. Ciò può aiutare a spiegare perchè, a dispetto delle forti dichiarazioni pre-elettorali, quasi tutti i leader siano oggi molto cauti nel definire le loro future scelte verso Musharraf e il suo circolo di sostenitori, non dimenticando che il PPP ha oggi una leadership non ancora ben definita. In ogni caso, è facile prevedere che i leader, nei giorni a venire, faranno mostra di notevole pragmatismo nel decidere i futuri scenari. Dunque, non dovrebbe destare sorpresa l'assistere ad alleanze tra ex-acerrimi avversari, come accaduto in passato e come, d'altra parte, avviene in generale nella politica del subcontinente.Del resto, durante il giuramento di oggi del neo Parlamento, i due leader, Asif Ali Zardari per il Ppp e Nawaz Sharif per la Pml-N, hanno dichiarato che si tratta di un evento storico per il Pakistan, e un'occasione unica per reinstaurare finalmente la democrazia nel paese. La prima decisione che il nuovo governo prenderà una volta insediato, infatti, sarà (o dovrebbe essere) quella di rimettere al loro posto i giudici che erano stati destituiti nel novembre scorso, quando Musharraf aveva dichiarato lo stato di emergenza, reprimendo le libertà civili. Ma siamo in presenza di una coalizione che, pur essendo talmente ampia e frastagliata da somigliare più all’armata Brancaleone che a una coalizione politica, non raggiunge tuttavia la famosa maggioranza dei due terzi necessaria a mettere Musharraf in seria difficoltà. Ancora lui…
AGGIORNAMENTO (30 marzo 2008):
Il nuovo parlamento pakistano si è riunito per la prima la scorsa settimana e nei prossimi giorni dovrebbe essere eletto il nuovo Primo Ministro. La scelta spetta al Pakistan People's Party (PPP), il partito della defunta Benazir Bhutto che è ha ottenuto la maggior parte dei consensi alle ultime elezioni. Generalmente in Pakistan è il leader del partito vincente a ricoprire l'incarico di Primo Ministro, ma in questo caso non sarà possibile poiché Asif Ali Zardari, il vedovo di Benazir Bhutto della quale ha raccolto l'eredità politica, non è eleggibile poiché non è un membro del parlamento. L'omicidio della Bhutto è infatti avvenuto a candidature ormai chiuse e prima Zardari non si occupava direttamente di politica. In ogni caso, sebbene la scelta spetti al PPP, il nuovo Primo Ministro dovrà essere una persona gradita anche al secondo partito pakistano, la Pakistan Muslim League – N (Nawaz), formazione con la quale dovrà realizzare la coalizione di governo. Sicuramente non sarà Nawaz Sharif, leader del PML-N, anch'esso non membro del parlamento. Fino a poco tempo fa il favorito era Makhdoom Amin Fahim, il vicepresidente del PPP, ma Zardari si sarebbe opposto alla sua elezione.Per quanto riguarda la formazione del nuovo governo, l'accordo tra Asif Ali Zardari e Nawaz Sharif sarebbe già stato raggiunto. La PML-N ha chiesto alcuni ministeri strategici, come Difesa e Finanza. La distribuzione dei ministeri tra i due principali partiti dovrebbe comunque avvenire in base a un criterio proporzionale concordato tra i due leader. Il PPP avrà il 54% dei seggi nel gabinetto federale, mentre il PML-N ne otterrà il 40%. Almeno in una prima fase il numero dei ministri dovrebbe essere di 15, per poi espandersi successivamente fino a 20. In ogni caso, chiunque sia a guidarlo, il nuovo governo pakistano non darà vita facile al Presidente Mushrraf. Basti pensare che i due partiti di maggioranza hanno già deciso il reinsediamento, entro 30 giorni da oggi, dei giudici della Corte Suprema che Musharraf aveva deposto prima delle elezioni.
APPROFONDIMENTI:
-








.jpg)