L'omicidio politico di Saddam Hussein
Etichette:
GREATER MIDDLE EAST
 Poco più di un anno fa (26 dicembre 2006) l’esecuzione di Saddam Hussein gettava ombre sul processo di pacificazione dell’Iraq. Da allora è sempre più evidente il fallimento di una non dichiarata strategia della vendetta. Dalla ventilata “svolta epocale”, all'”uccisione per procura” decisa dal grottesco remake di Norimberga.
Poco più di un anno fa (26 dicembre 2006) l’esecuzione di Saddam Hussein gettava ombre sul processo di pacificazione dell’Iraq. Da allora è sempre più evidente il fallimento di una non dichiarata strategia della vendetta. Dalla ventilata “svolta epocale”, all'”uccisione per procura” decisa dal grottesco remake di Norimberga.1. La scontata sentenza di morte contro Saddam Hussein, prodotta apparentemente da quella parodia di Norimberga che è stato il suo processo, era in realtà già stata scritta ed eseguita nel dicembre del 2003, quando George Bush, il presidente della nazione occupante, aveva dichiarato alla BBC subito dopo la cattura che soltanto "la pena ultima" (la morte) sarebbe stato il giusto castigo per il "disgustoso tiranno". Caso chiuso e Capodanno con il patibolo.
Non sono serviti tribunali internazionali, giuristi e giudici di peso e di altre nazioni, come fu appunto nel Processo di Norimberga. La sentenza era già stata depositata a priori. Tutto il resto, il processo con giudici destituiti e cambiati a piacere dall'immaginario governo di Bagdad (se non quando addirittura assassinati), le procedure seguite frettolosamente e fuori dai canoni giuridici internazionali, la sentenza, l'appello farsa che ha richiesto ben 15 minuti di delibere, l'esecuzione, sono pantomime organizzate per dare una parvenza di legittimità giudiziaria alla vendetta finale del vincitore contro il vinto. Nella guerra - insieme globale e privata - che dal 1991 vede in campo Stati Uniti e Iraq (ma senza che mai l'Iraq abbia aggredito gli Stati Uniti) alla fine il clan texano dei Bush ha saldato il conto con il clan sunnita dei Takriti. E il figlio ha potuto vergognosamente esibire la tanto agognata testa del nemico al padre. Nonostante non ce ne fosse alcun bisogno.
Il personaggio Saddam Hussein aveva perso la popolarità anche tra i sunniti iracheni, i quali oggi lo considerano responsabile del loro proprio declino con l'ascesa degli sciiti al governo. Tanto che hanno l'impressione di pagare oggi, come comunità, i crimini del raìs. Ma, nel mondo arabo sunnita in generale, mentre la virtù pedagogica della guerra contro il terrore ha cessato di avere peso ormai da tempo, la democratizzazione del Medio Oriente tanto celebrata dai neocon, non è riuscita a creare un modello alternativo. La trappola irachena funziona inesorabile. Abbattuto il tiranno si è disgregato il paese e la sua condanna alla forca, giustificata ma decisa in modo sommario, lo ha promosso al ruolo di martire e simbolo della rivolta sunnita che ancora continua, alimenta al tempo stesso l'intransigenza sciita che punta su una rapida esecuzione della sentenza. Il trofeo di Bush continua a trasformarsi in un boomerang. Esso prende il nome di guerra civile.
2. Una guerra civile originata da una vittoria americana mancata, e che proprio per questo, in quanto conseguenza della fallita impresa della superpotenza, sta sconvolgendo l'area geopolitica al momento più critica del mondo. Nulla è finito con Saddam sottoterra. Quando George W. Bush definiva l'esecuzione "una pietra miliare", sulla strada della democrazia irachena in gestazione, cercava di dare l'impressione che l'immagine dell'ex raìs alla forca chiudesse un capitolo e ne aprisse un altro. Per questa strada si è andati, invece, verso una situazione tragicamente confusa e irrisolta, dalla quale né lui né i suoi generali sanno in verità come uscire, né hanno un'idea di come andrà a finire.
L'impiccagione di Saddam è stato un episodio della guerra civile e in una guerra civile i giudici non hanno alternative. A Bagdad era come se sulle loro nuche fossero puntate delle pistole. Non che ci fossero dubbi sulla colpevolezza di Saddam. Era un campione dei crimini contro l'umanità. Per il numero di vittime Pinochet gli era di gran lunga inferiore - e comunque è morto nel suo. I giudici di Bagdad non hanno avuto il tempo di esaminare tutti i delitti di Saddam, individuali o di massa. Hanno giudicato la strage del 1982 (143 sciiti uccisi nel villaggio di Jubail), ed è bastata per infliggergli la pena capitale. Non hanno avuto il tempo di passare in rassegna tutte le repressioni ordinate contro i curdi e gli sciiti, che hanno fatto decine di migliaia di morti. Spesso con armi chimiche.
Se George W. Bush avesse voluto un processo regolare, se avesse voluto una giustizia imparziale, avrebbe consegnato Saddam Hussein al Tribunale Penale Internazionale dell'Aja. Il processo, è vero, sarebbe durato anni e non si sarebbe concluso con una condanna a morte, perché il TPI esclude la pena capitale, ma ci sarebbe stato un dibattimento trasparente, lontano dalle passioni di una guerra civile. L'Amministrazione americana non poteva tuttavia consegnare Saddam a una giurisdizione che essa non riconosce. Gli Stati Uniti, come altre potenze, tra queste la Cina e la Russia, non hanno infatti ratificato il trattato che ha istituito il TPI. Né Washington, né Mosca, né Pechino vogliono correre il rischio di vedere un giorno i propri responsabili sul banco degli imputati. E in tutti i modi non era gradito un processo durante il quale sarebbero emerse le innumerevoli complicità tra Saddam e gli americani, in particolare quando Saddam era il potente rais laico che si opponeva all'islamismo iraniano. Durante la guerra Iran-Iraq, egli rappresentava la grande diga di fronte alla Repubblica islamica di Khomeini. E quando, dopo la prima guerra del Golfo (1991) annientò la guerriglia sciita nel Sud dell'Iraq, gli americani che l'avevano favorita e illusa, lasciarono Saddam agire indisturbato. Di questo non si è parlato nell'aula bunker del tribunale speciale iracheno.
3. Dal punto di vista giuridico, c’è chi ha evidenziato che la legislazione irachena è disorganica e contraddittoria[1]. Inoltre lo Statuto del Tribunale speciale era ed è tuttora volutamente ambiguo in quanto, in materia di pene, rimanda genericamente alla legislazione irachena, e cioè essenzialmente al codice penale del 1969, che tra l'altro non prevedeva affatto i crimini per cui Saddam Hussein è stato giudicato e condannato, e cioè i crimini contro l'umanità. Il susseguirsi di tesi giuridiche diverse circa l'eseguibilità della pena capitale era da leggere in realtà come indice di un grave conflitto politico, in Iraq, tra falchi e colombe - queste ultime evidentemente inclini a rinviare nel tempo l'esecuzione, per paura di gravi ripercussioni sul futuro del paese.
A leggere le norme pertinenti della legislazione irachena, è chiaro che l'approvazione della pena capitale da parte del Presidente Talabani è stata necessaria: la Costituzione irachena del 2005, all'Articolo 70, prevede tra i poteri del Presidente quello di "ratificare" le pene capitali pronunciate "dalle corti competenti", mentre il codice di procedura penale del 1971 e la Costituzione del 1990 assegnavano al Presidente anche il potere di commutare la pena o graziare il condannato (dal 2005 può, appunto, solo approvare o meno la sentenza capitale). Resta il fatto che la pena non può essere eseguita senza il suo assenso. In mancanza del quale, la pena è sospesa o rinviata nel tempo. E' chiaro che si è trattata di una decisione puramente politica, da prendere alla luce di considerazioni relative all'impatto che avrebbe l'esecuzione capitale sulla popolazione irachena e sulla guerra civile in corso, nonché sugli altri Stati. In questo, come in altri casi, il diritto serve dunque solo come pretesto o paravento per scelte politiche.
4. Infine, due considerazioni. Anzitutto, l'esecuzione della condanna ha confermato quanto fosse fallace l'affermazione della Casa Bianca secondo cui l'impiccagione dell'ex dittatore avrebbe dimostrato che oggi la "rule of law", e cioè lo stato di diritto, è subentrato alla tirannide ("rule of a tyrant"). In realtà le gravi irregolarità del processo, la violazione dei diritti della difesa e l'irrogazione della pena capitale (vietata da tutti i tribunali penali internazionali) provano che ciò non è vero.
Inoltre, uno degli effetti deleteri dell'esecuzione capitale dell'ex dittatore ha permesso la caduta di tutti gli ulteriori processi previsti per imputazioni molto più gravi: dall'uso di armi chimiche contro i curdi iracheni (nel 1988, la campagna denominata ‘Anfal’) a quello delle stesse armi contro l'Iran, nella guerra tra i due paesi (1980-88) – fatto, questo, ammesso dallo stesso imputato nelle ultime settimane, nel corso dell’appello. Un'ammissione che avrebbe dovuto indurre a non interrompere quel processo (in cui è accusato di genocidio) o, meglio ancora, ad aprirne un altro, per crimini di guerra. E, invece, è caduto anche il processo per l'aggressione contro il Kuwait (1990) e l'altro per la repressione delle insurrezioni di curdi e shiiti nel 1991.
In particolare merita questa seconda repressione. I curdi iracheni aiutarono logisticamente (quindi anche con informazioni di intelligence sul territorio) gli americani sia nella prima che nella seconda guerra del Golfo. Nella prima credettero ingenuamente (forse perché convinti da Bush padre) che gli americani sarebbero arrivati fino a Bagdad e avrebbero destituito Saddam. Il quale, a guerra finita e dopo aver salvato la pelliccia, da buon dittatore che si rispetti infierì su di loro, con i gas forniti negli anni '80 dalla 'democrazia' di Washington. Stessa cosa hanno fatto in questi anni, ma ora possono a buon ragione sperare in un loro stato autonomo, dotato tra l'altro di un'arma che funziona sempre, il petrolio, anche se un Kurdistan iracheno autonomo non va a genio a molti, a cominciare dalla Turchia.
Corsi e ricorsi storici a parte, l’insegnamento che si tra da tutta questa vicenda è che una delle poche ragioni per cui i processi dei vincitori contro i vinti si possono salvare è che comunque si fa luce su episodi complessi, oscuri e ambigui, accertando fatti controversi e rivelando cose prima nascoste. Con la morte di Saddam, non è stata assolta nemmeno questa funzione di chiarificazione storica. Se così è, qualcuno potrebbe chiedersi se allora non sarebbe stato meglio uccidere subito Saddam, al momento dell'arresto. Certo, sarebbe stato un atto gravissimo, ma che avrebbe almeno evitato la farsa del processo.
NOTE:
[1] Antonio Cassese - uno dei più autorevoli esperti e studiosi del diritto internazionale - Una sentenza nel caos giuridico, Corriere della Sera, 28 dicembre 2006.
Non sono serviti tribunali internazionali, giuristi e giudici di peso e di altre nazioni, come fu appunto nel Processo di Norimberga. La sentenza era già stata depositata a priori. Tutto il resto, il processo con giudici destituiti e cambiati a piacere dall'immaginario governo di Bagdad (se non quando addirittura assassinati), le procedure seguite frettolosamente e fuori dai canoni giuridici internazionali, la sentenza, l'appello farsa che ha richiesto ben 15 minuti di delibere, l'esecuzione, sono pantomime organizzate per dare una parvenza di legittimità giudiziaria alla vendetta finale del vincitore contro il vinto. Nella guerra - insieme globale e privata - che dal 1991 vede in campo Stati Uniti e Iraq (ma senza che mai l'Iraq abbia aggredito gli Stati Uniti) alla fine il clan texano dei Bush ha saldato il conto con il clan sunnita dei Takriti. E il figlio ha potuto vergognosamente esibire la tanto agognata testa del nemico al padre. Nonostante non ce ne fosse alcun bisogno.
Il personaggio Saddam Hussein aveva perso la popolarità anche tra i sunniti iracheni, i quali oggi lo considerano responsabile del loro proprio declino con l'ascesa degli sciiti al governo. Tanto che hanno l'impressione di pagare oggi, come comunità, i crimini del raìs. Ma, nel mondo arabo sunnita in generale, mentre la virtù pedagogica della guerra contro il terrore ha cessato di avere peso ormai da tempo, la democratizzazione del Medio Oriente tanto celebrata dai neocon, non è riuscita a creare un modello alternativo. La trappola irachena funziona inesorabile. Abbattuto il tiranno si è disgregato il paese e la sua condanna alla forca, giustificata ma decisa in modo sommario, lo ha promosso al ruolo di martire e simbolo della rivolta sunnita che ancora continua, alimenta al tempo stesso l'intransigenza sciita che punta su una rapida esecuzione della sentenza. Il trofeo di Bush continua a trasformarsi in un boomerang. Esso prende il nome di guerra civile.
2. Una guerra civile originata da una vittoria americana mancata, e che proprio per questo, in quanto conseguenza della fallita impresa della superpotenza, sta sconvolgendo l'area geopolitica al momento più critica del mondo. Nulla è finito con Saddam sottoterra. Quando George W. Bush definiva l'esecuzione "una pietra miliare", sulla strada della democrazia irachena in gestazione, cercava di dare l'impressione che l'immagine dell'ex raìs alla forca chiudesse un capitolo e ne aprisse un altro. Per questa strada si è andati, invece, verso una situazione tragicamente confusa e irrisolta, dalla quale né lui né i suoi generali sanno in verità come uscire, né hanno un'idea di come andrà a finire.
L'impiccagione di Saddam è stato un episodio della guerra civile e in una guerra civile i giudici non hanno alternative. A Bagdad era come se sulle loro nuche fossero puntate delle pistole. Non che ci fossero dubbi sulla colpevolezza di Saddam. Era un campione dei crimini contro l'umanità. Per il numero di vittime Pinochet gli era di gran lunga inferiore - e comunque è morto nel suo. I giudici di Bagdad non hanno avuto il tempo di esaminare tutti i delitti di Saddam, individuali o di massa. Hanno giudicato la strage del 1982 (143 sciiti uccisi nel villaggio di Jubail), ed è bastata per infliggergli la pena capitale. Non hanno avuto il tempo di passare in rassegna tutte le repressioni ordinate contro i curdi e gli sciiti, che hanno fatto decine di migliaia di morti. Spesso con armi chimiche.
Se George W. Bush avesse voluto un processo regolare, se avesse voluto una giustizia imparziale, avrebbe consegnato Saddam Hussein al Tribunale Penale Internazionale dell'Aja. Il processo, è vero, sarebbe durato anni e non si sarebbe concluso con una condanna a morte, perché il TPI esclude la pena capitale, ma ci sarebbe stato un dibattimento trasparente, lontano dalle passioni di una guerra civile. L'Amministrazione americana non poteva tuttavia consegnare Saddam a una giurisdizione che essa non riconosce. Gli Stati Uniti, come altre potenze, tra queste la Cina e la Russia, non hanno infatti ratificato il trattato che ha istituito il TPI. Né Washington, né Mosca, né Pechino vogliono correre il rischio di vedere un giorno i propri responsabili sul banco degli imputati. E in tutti i modi non era gradito un processo durante il quale sarebbero emerse le innumerevoli complicità tra Saddam e gli americani, in particolare quando Saddam era il potente rais laico che si opponeva all'islamismo iraniano. Durante la guerra Iran-Iraq, egli rappresentava la grande diga di fronte alla Repubblica islamica di Khomeini. E quando, dopo la prima guerra del Golfo (1991) annientò la guerriglia sciita nel Sud dell'Iraq, gli americani che l'avevano favorita e illusa, lasciarono Saddam agire indisturbato. Di questo non si è parlato nell'aula bunker del tribunale speciale iracheno.
3. Dal punto di vista giuridico, c’è chi ha evidenziato che la legislazione irachena è disorganica e contraddittoria[1]. Inoltre lo Statuto del Tribunale speciale era ed è tuttora volutamente ambiguo in quanto, in materia di pene, rimanda genericamente alla legislazione irachena, e cioè essenzialmente al codice penale del 1969, che tra l'altro non prevedeva affatto i crimini per cui Saddam Hussein è stato giudicato e condannato, e cioè i crimini contro l'umanità. Il susseguirsi di tesi giuridiche diverse circa l'eseguibilità della pena capitale era da leggere in realtà come indice di un grave conflitto politico, in Iraq, tra falchi e colombe - queste ultime evidentemente inclini a rinviare nel tempo l'esecuzione, per paura di gravi ripercussioni sul futuro del paese.
A leggere le norme pertinenti della legislazione irachena, è chiaro che l'approvazione della pena capitale da parte del Presidente Talabani è stata necessaria: la Costituzione irachena del 2005, all'Articolo 70, prevede tra i poteri del Presidente quello di "ratificare" le pene capitali pronunciate "dalle corti competenti", mentre il codice di procedura penale del 1971 e la Costituzione del 1990 assegnavano al Presidente anche il potere di commutare la pena o graziare il condannato (dal 2005 può, appunto, solo approvare o meno la sentenza capitale). Resta il fatto che la pena non può essere eseguita senza il suo assenso. In mancanza del quale, la pena è sospesa o rinviata nel tempo. E' chiaro che si è trattata di una decisione puramente politica, da prendere alla luce di considerazioni relative all'impatto che avrebbe l'esecuzione capitale sulla popolazione irachena e sulla guerra civile in corso, nonché sugli altri Stati. In questo, come in altri casi, il diritto serve dunque solo come pretesto o paravento per scelte politiche.
4. Infine, due considerazioni. Anzitutto, l'esecuzione della condanna ha confermato quanto fosse fallace l'affermazione della Casa Bianca secondo cui l'impiccagione dell'ex dittatore avrebbe dimostrato che oggi la "rule of law", e cioè lo stato di diritto, è subentrato alla tirannide ("rule of a tyrant"). In realtà le gravi irregolarità del processo, la violazione dei diritti della difesa e l'irrogazione della pena capitale (vietata da tutti i tribunali penali internazionali) provano che ciò non è vero.
Inoltre, uno degli effetti deleteri dell'esecuzione capitale dell'ex dittatore ha permesso la caduta di tutti gli ulteriori processi previsti per imputazioni molto più gravi: dall'uso di armi chimiche contro i curdi iracheni (nel 1988, la campagna denominata ‘Anfal’) a quello delle stesse armi contro l'Iran, nella guerra tra i due paesi (1980-88) – fatto, questo, ammesso dallo stesso imputato nelle ultime settimane, nel corso dell’appello. Un'ammissione che avrebbe dovuto indurre a non interrompere quel processo (in cui è accusato di genocidio) o, meglio ancora, ad aprirne un altro, per crimini di guerra. E, invece, è caduto anche il processo per l'aggressione contro il Kuwait (1990) e l'altro per la repressione delle insurrezioni di curdi e shiiti nel 1991.
In particolare merita questa seconda repressione. I curdi iracheni aiutarono logisticamente (quindi anche con informazioni di intelligence sul territorio) gli americani sia nella prima che nella seconda guerra del Golfo. Nella prima credettero ingenuamente (forse perché convinti da Bush padre) che gli americani sarebbero arrivati fino a Bagdad e avrebbero destituito Saddam. Il quale, a guerra finita e dopo aver salvato la pelliccia, da buon dittatore che si rispetti infierì su di loro, con i gas forniti negli anni '80 dalla 'democrazia' di Washington. Stessa cosa hanno fatto in questi anni, ma ora possono a buon ragione sperare in un loro stato autonomo, dotato tra l'altro di un'arma che funziona sempre, il petrolio, anche se un Kurdistan iracheno autonomo non va a genio a molti, a cominciare dalla Turchia.
Corsi e ricorsi storici a parte, l’insegnamento che si tra da tutta questa vicenda è che una delle poche ragioni per cui i processi dei vincitori contro i vinti si possono salvare è che comunque si fa luce su episodi complessi, oscuri e ambigui, accertando fatti controversi e rivelando cose prima nascoste. Con la morte di Saddam, non è stata assolta nemmeno questa funzione di chiarificazione storica. Se così è, qualcuno potrebbe chiedersi se allora non sarebbe stato meglio uccidere subito Saddam, al momento dell'arresto. Certo, sarebbe stato un atto gravissimo, ma che avrebbe almeno evitato la farsa del processo.
NOTE:
[1] Antonio Cassese - uno dei più autorevoli esperti e studiosi del diritto internazionale - Una sentenza nel caos giuridico, Corriere della Sera, 28 dicembre 2006.










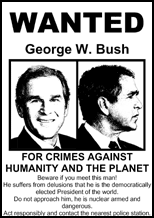


Nessun commento:
Posta un commento